
Nella mia città natale, dove torno una sola volta ogni anno per poche ore, molte cose appaiono come ferme nel tempo, del quale pure mostrano chiari segni, come cicatrici o rughe su un volto; altre sono scomparse, ad esempio certi negozi che hanno chiuso dopo molti decenni di attività, alcuni sostituiti da altri, che per lo più vendono articoli insignificanti e labili come fumo. C’erano poi, ai tempi della mia giovinezza e poi forse ancora per molti anni, quattro sale cinematografiche, ma ne rimane soltanto una, quasi miracolosamente (mi ero preparato a non vederne più nessuna). La maggior parte dei film che vidi in quell’epoca della mia vita venivano proiettati in quella quasi all’inizio della via principale, e proprio lì davanti sono passato ieri nella mia prima passeggiata nel centro della città dopo diversi anni. Nessun segno, all’esterno, faceva pensare all’esistenza di un cinema, neppure in un tempo passato, e chiunque arrivasse lì per la prima volta non potrebbe immaginarlo. L’ampio androne che si attraversava prima di entrare nel cinema, nell’anticamera dove si trovava la cassa, ora è vuoto, ‘ravvivato’ soltanto su un lato da due vetrine di un negozio di cui non ricordo più il genere (scarpe, abiti, articoli per cucina… chissà), che gettano un po’ di luce artificiale nell’androne, altrimenti privo di una propria illuminazione. Ma non mi sono fatto scoraggiare dalle apparenze e ho continuato ad avanzare, con passi incerti e misurati, verso il fondo, attratto da due grandi tende nere. Una volta raggiunte, dopo una breve esitazione mista ad apprensione (temevo di vedere qualcosa che non mi sarebbe piaciuto, che non avrei riconosciuto), ne ho un poco scostata una, gettando quindi uno sguardo là dentro. Era tutto avvolto nel buio fitto, non si poteva distinguere alcuna forma, eppure ebbi, per un attimo, l’intensa percezione che quel luogo non fosse vuoto, che anzi ci fosse rimasto qualcosa, abbandonato all’oblio e invisibile ma ancora presente, come tanti anni fa, quando entravo e uscivo da lì quasi ogni giorno. Era come se tutti quei lontani momenti, da me vissuti tanto intensamente, fossero stati inghiottiti da quel nero nulla, di cui ora facevano parte, materiandolo.
Ho rimesso subito la tenda nella posizione che aveva prima del mio arrivo, sistemata in modo tale da nascondere alla vista le porte a vetri della sala, e mi sono allontanato da quel luogo – ormai inaccessibile per sempre – che tanto contò per me in un tempo lontano della mia vita, dopo essere tornato un’ultima volta sulla sua soglia, per un attimo in bilico fra passato e presente. E forse, fra la vita e la morte.
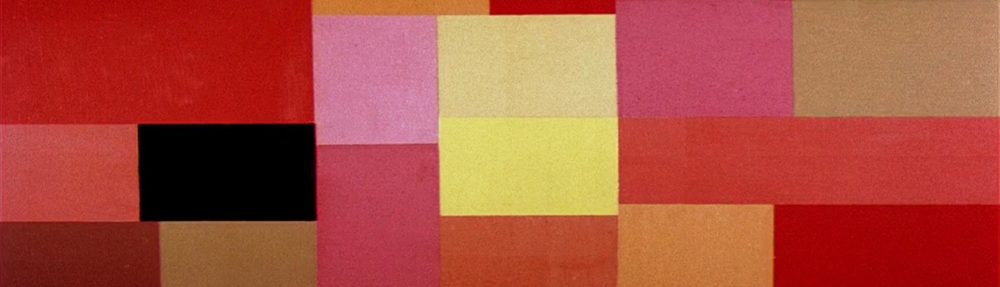




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.